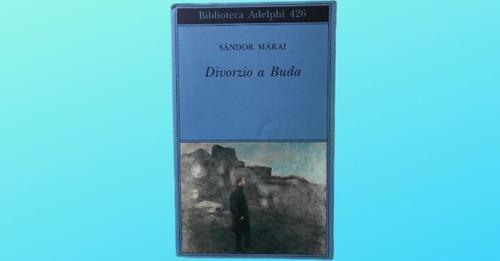Basta sfogliare i registri parrocchiali
Il periodo invernale, nel secoli scorsi e sino ai nostri recenti anni Sessanta, era considerato, quasi per antonomasia, il tempo preferito per contrarre matrimonio. Ci si sposava per lo più tra dicembre e febbraio, perché ol mis de màrs le scomensàa a cantà ol cucù e… besognàa ‘ndà a fà ergót!… Basta sfogliare i registri dei matrimoni, depositati in municipio o in parrocchia, per rendersi conto di tale consuetudine. L’inverno ha sempre posto al centro dell’attenzione la famiglia rurale, che si ricompone nell’antica dimora della contrada: tornavano a casa i commercianti ambulanti di Costa, rimpatriavano i carbonai e boscaioli di San Simù sparsi nelle foreste alpine e sull’Appennino, rincasavano pure muratori, pecaprìde e minatori già impegnati per molti mesi in opere di costruzione di case, tunnel e trafori alpini, strade nei Paesi del Nord Europa. La contrada, il villaggio, la valle diventavano lo spazio dove convergevano esperienze diverse, si scambiavano informazioni, si mettevano a confronto momenti anche amari di vita vissuti in terre lontane con protagonismo e sacrificio; ma rappresentavano anche lo spazio dove nascevano e si trasmettevano leggende e miti, costruiti sulla reinterpretazione fantastica di avvenimenti realmente accaduti. Nel frattempo, però, si definivano i futuri programmi di lavoro, gli scenari possibili per nuove avventure. È stata la famiglia il motore primo di questo straordinario fermento.

Matrimonio di Francesco Carminati (1933), figlio primogenito di Luigi ed Elvira Manzinali, con Pierina Locatelli (1939), miei genitori. Chiesa parrocchiale di San Simù, 28 gennaio 1961. Archivio Centro Studi Valle Imagna.
Sposarsi tra l’Epifania e le Ceneri
Quasi tutte le fotografie di gruppi familiari – gli immancabili retràcc commissionati al fotografo, ol Dante Capelù de la Felìsa, oppure, prima ancora, ol Batìsta, che le stàa sö a la Tór de Sant’Imbù, o ancora ol Nandì de Locadèl – incorniciate e appese nella camera da letto dol Tata, accanto all’immagine della Sacra Famiglia di Nazareth, o del Sacro Cuore di Gesù, sono scattate l’inverno, quando c’era più tempo a disposizione e si rallentava anche l’attività agricola. Il lavoro non era così pressante. Il periodo preferito per sposàs era compreso tra l’Epifania e le Ceneri. La tradizione religiosa voleva infatti che non si celebrassero matrimoni né in Avvento, né in Quaresima. La popolazione era attenta a queste cose e commentava sottovoce: “La s’è sposàda en tép de Quarìsma: chesà come la sarà quèla! Magàre la spécia…“. Il giorno preferito per la celebrazione è sempre stato il sabato, anche se nulla vietava che, per particolari esigenze, il matrimonio si svolgesse in altri giorni feriali: venivano comunque sempre esclusi la domenica, per non disturbare le altre funzioni religiose collettive, e il venerdì, ol dé dol Signùr.

Festa di matrimonio. Corna Imagna, primi decenni del Novecento. Archivio Centro Studi Valle Imagna.
La spusa la endàa a stà en cà do l’óm
La famiglia, dunque, fondata sul matrimonio, ha rappresentato nei secoli il “cuore” dell’inverno, un faro per i singoli membri, elemento aggregante e cementificatore di interessi collettivi, volano di trasmissione di comportamenti, attività, valori, modalità relazionali. La rigida struttura delle relazioni parentali, organizzate su un modello gerarchico piramidale, con al vertice la figura dol Tata, ha garantito la sopravvivenza dei gruppi sociali anche nei periodi più difficili, durante guerre e carestie. La famiglia estesa riusciva a colmare il vuoto di un suo membro venuto a mancare, o provvisoriamente assente, per un atteggiamento di corresponsabilità di tutti i suoi componenti, anche sul piano educativo. Il matrimonio di un figlio costituiva un arricchimento per il gruppo parentale, mentre quello di una figlia una perdita, perché la tusa avrebbe definitivamente lasciato la casa per andare ad incrementare un’altra famiglia, quella del marito. La regola era che la spusa la endàa a stà en cà do l’óm. Nell’espressione del Tata: “De pedàgn ghe n’è tànci, ma de fèmne ghe n’è póche” viene bene riassunta la sua fondata preoccupazione circa l’ingresso della spusa en faméa, in relazione alla sua capacità di adeguarsi alle abitudini di vita concreta, come anche ai valori e ai modelli economici e culturali propri del gruppo di destinazione. Di più: gli altri componenti della famiglia come avrebbero reagito di fronte all’ingresso della nuova spusa? Anche per questo motivo numerosi rapporti di coniugio si sviluppavano all’interno della contrada, mediante scambi matrimoniali tra famiglie aventi la medesima tradizione insediativa ed occupazionale. Era naturale che il giovane boscaiolo cercasse moglie in una famiglia di boscaioli e ciò valeva per i muratori e i bergamini. Un motivo di sicurezza in più.

Luigi Carminati (1907) ed Elvira Manzinali (1911) – miei nonni paterni – una settimana prima del loro matrimonio (1932), al ritorno dal Santuario della Cornabusa, nello studio fotografico del Nandì (Arrigoni) di Locatello. Archivio Centro Studi Valle Imagna.
L’invito a cena ai futuri consuoceri
Il matrimonio de ü tus era un evento che coinvolgeva tutta la famiglia, dato che la sò fèmna la sarèss ‘ndàcia a stà en de la stèsa cà. Prima de tacà fò i carte fò en césa e fò en cümü, e s’fàa i pàcc, ossia si procedeva a definire in famiglia gli accordi preliminari al matrimonio. Era un avvenimento importante, perché i genitori degli sposi si riunivano insieme a descüt: il rituale consisteva in un invito a cena che i genitori della sposa rivolgevano ai futuri consuoceri. Alla cena partecipavano anche i due fidanzati e uno zio e una zia della sposa, quali testemòne che la tusa la gh’à dìcc de sé al sò óm. L’incontro aveva sostanzialmente tre obiettivi: formalizzare la volontà dei rispettivi figli al matrimonio, in particolare della donna; inoltrare ufficialmente la richiesta dei genitori dello sposo al padre e alla madre della ragazza per acconsentire il matrimonio della figlia e il suo inserimento nella nuova famiglia; infine programmare gli adempimenti successivi, dalle pubblicazioni alla celebrazione del matrimonio. Solamente ad avvenuta approvazione dei “patti matrimoniali”, il progetto matrimoniale diventava di pubblico dominio. “Ià fàcc i pàcc!…”, si affermava, per indicare la conclusione degli accordi: era ormai spianata la strada verso il matrimonio. In seguito il giovane completava l’allestimento della camera nuziale, riservatagli nella casa del Tata, mentre la ragazza ultimava il suo modesto corredo. Era giunto il momento de ferà la spusa! L’espressione (ferà la spusa) può sembrare eccessivamente forte, ma esprime bene l’incardinamento della donna nella famiglia del marito. Si trattava di prenotare la caretèla per endà a Bèrghem a crompà l’òr, che consisteva nella fede nuziale (ìra) della sposa, alla quale, solamente se le condizioni economiche lo permettevano, si aggiungeva la spìla e la cadenèla, eccezionalmente anche ü pèr de urigì. Scendevano, di norma, ol missìr con lo sposo e la mamma della sposa. Il poco oro acquistato andava a favore della sposa. Elvira, mia nonna, alla quale avevo chiesto come mai la fede nuziale solo alla spusa, mi spiegò la ragione: “Ma perchè l’ìa la fèmna che la cambiàa cà e faméa. L’óm, dac da sposàt, e l’restàa en de la sò cà e co la sò faméa!“.
Il rituale dei confetti
La fede nuziale, che solo la donna era tenuta a portare, estendeva il vincolo di fedeltà e di sottomissione della spusa non solo al marito, ma anche nei confronti della nuova casa e famiglia di destinazione. La ìra al dito costituiva un segno tangibile di appartenenza della donna alla famiglia del marito. Sempre il padre dello sposo provvedeva ad acquistare a Bergamo i confècc e dac ol capèl per ol sò tus, che a seguito del matrimonio avrebbe portato con dignità. Sempre a carico del padre dello sposa erano l’arredamento della stanza da letto, il pranzo e l’abito di nozze della sposa: paltò, estìna, scarpète, calsète e ol vèl di colore nero. L’utilizzo del vestito bianco con la coda a strascico è un’invenzione recente. Nel corso delle ultime settimane che precedevano le nozze, i spus i pestàa la nìv per ‘ndà a dà fò i confècc: era un momento importante della ritualità pre-matrimoniale, che dichiarava di fronte ai parenti, ma anche a tutti gli abitanti delle contrade, l’impegno a contrarre matrimonio. La domanda frequente, che veniva rivolta a quei fidanzati che da tép i parlàa ensèma, ma che i s’ìa gnamò mia decidìt, era appunto la seguente: “Quand’il che en mangia e confècc?”. La settimana prima del matrimonio, era consuetudine che gli sposi si recassero al santuario della Madonna della Cornabusa a sentì mèsa, confesàs e ciapà la cumeniù. Al ritorno dal santuario, la nonna Elvira, col sò Lüìge, fecero due soste, durante il ritorno a Canito, la loro contrada: la prima dal Begióla, a la Felìsa, a maià pà e mortadèla, mentre la seconda dal Nandì, fò en Locadèl, a fà ol retràcc.
L’altra vita della giovane sposa
Non entro, ora, nel merito della cerimonia nuziale (che richiederebbe un altro testo): quel giorno rappresentava per la spusa l’inizio di un periodo di lavoro, di fatica e di responsabilità maggiori rispetto alla vita da ragazza; per il marito, invece, cambiava poco. Passata la festa, per la giovane sposa cominciava un’altra vita, generalmente non meno dura e difficile della precedente, dal punto di vista soprattutto della convivenza con persone nuove, alle quali doveva rispetto, sottomissione e ubbidienza, per il semplice motivo che e tosà de la cà le gnìa dó da i scale, mentre lei la gnìa en cà da la pòrta! In fondo si sentiva ancora un’estranea. “Gh’ìe ‘nféna argógna a taià dó la polénta da la bàrgia“, ricordava la nonna, rievocando i primi giorni nella famiglia del marito. Con la celebrazione del matrimonio la spusa veniva immediatamente attratta dal sistema di vita del nuovo gruppo, fatta eccezione per una breve sospensione del regime della coabitazione coniugale. Dopo circa una settimana dal matrimonio, infatti, la sposa la ‘ndàa a fà i òt dé, ossia ritornava nella propria famiglia originaria, rimanendovi, comprese le notti, per otto giorni consecutivi. Trascorso tale periodo, nel giorno convenuto, il marito sarebbe andato a riprenderla col dèrel de pàn, entro il quale la sposa riponeva la dote assegnata. Ritornava, così, per rimanervi definitivamente, nella casa del marito con la sua dote. Si diceva che la spusa l’ìa ‘ndàcia a cà sò a tö la léngua, perché, anche in relazione alla consistenza dei beni introdotti nella sua nuova famiglia, poteva accrescere in prestigio personale e trovare finalmente la forza de dì la sò!…
Contributo di Antonio Carminati, direttore del Centro Studi Valle Imagna