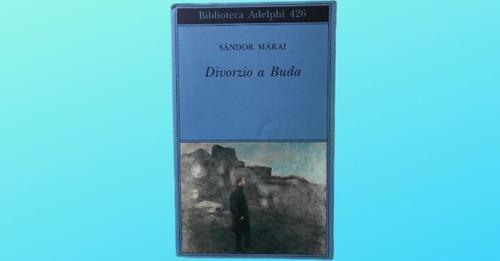In una sola settimana il calendario civile ci invita a riflettere su due grandi questioni del nostro tempo: la libertà, con annesse le conquiste democratiche e i principi-cardine della nostra civiltà occidentale (25 Aprile), e il lavoro (1° Maggio). Ce n’è quanto basta. Due argomenti strettamente collegati e conseguenziali, non solo nella celebrazione delle rispettive ricorrenze.
Lavoro elemento fondante di sovranità popolare
Il 25 Aprile è stato un punto di svolta: finalmente la guerra era terminata e i Tedeschi erano stati cacciati, ma l’Italia aveva perso e la sua economia era in ginocchio, piegata sotto i bombardamenti dei principali centri industriali e cittadini, mentre anche nelle campagne dilagava la disoccupazione. Importanti sfide attendevano l’agenda delle forze democratiche uscite dalla Resistenza, a partire della definizione della forma-Stato e, di conseguenza, dalla scritturazione delle nuove regole della convivenza civile. C’era lo Stato da rifondare. Tutto ciò avvenne in poco tempo, sull’onda di un periodo entusiasmante e ricco di fermenti sociali. C’era un intero Paese da ricostruire: una sfida raccolta dalle forze politiche, le quali, dando fiato allo spirito di convergenza nazionale e attribuendo finalmente la parola a tutto il popolo, donne comprese, hanno dapprima indetto il Referendum istituzionale (2 giugno 1946), quindi scritto la nuova Carta dei principi della Repubblica, entrata in vigore il primo gennaio 1948, dove all’articolo 1 si dichiara espressamente che la democrazia si fonda sul lavoro. Il lavoro, dunque, per i Padri costituenti, non è solamente una delle tanti componenti del nuovo disegno repubblicano, bensì rappresenta l’elemento fondante il principio della sovranità popolare. Il lavoro è innanzitutto un dovere, più che un diritto, e come tale da ricercare, perseguire, persino conquistare, più che attendere. Non è poco. L’Italia, oltre a rialzarsi dalla distruzione della guerra, doveva anche ritrovare e ricostruire la sua posizione sullo scacchiere delle relazioni internazionali. Il 3 gennaio 1947, il leader democristiano Alcide De Gasperi compì il famoso “Viaggio del pane” in America, ottenendo aiuti economici concreti: “… il pane per i nostri figli, il carbone per le nostre caldaie, le materie prime per rifare le nostre case, ferrovie, ospedali, fabbriche, scuole, chiese…”. Il Piano Marshall avrebbe poi completato il programma per la ripresa di tutta l’Europa. La contropartita è stata, per l’Italia, la cacciata dal governo di Comunisti e Socialisti. Era l’inizio di quel clima da guerra fredda che caratterizzò la vita politica mondiale nei decenni successivi.
Una deportazione economica
In quel periodo vennero stipulati una serie di accordi bilaterali tra il governo italiano e altri Stati, finalizzati ad incentivare l’emigrazione all’estero di ingenti masse di lavoratori, quale nuova opportunità per dare inizio alla rinascita del Paese. Così è stato. Tra il 1946 e il 1947 sono emigrati circa ottantaquattromila italiani, soprattutto contadini provenienti dalle campagne, diretti dapprima ancora in Argentina, Canada e Australia, poi nei Paesi d’oltralpe più vicini. Ricordiamo, per tutti, il patto stipulato il 23 giugno 1946 tra Italia e Belgio, tramite il quale quest’ultimo si impegnava a fornire duecento chilogrammi al giorno di carbone in cambio di cinquantamila lavoratori entro un anno. Negli anni successivi seguirono importanti accordi anche con la Svizzera e la Germania, che hanno movimentano un’ingente quantità di persone. L’emigrazione ha cessato così di essere un evento pionieristico, limitato alle persone più intraprendenti, per diventare un fatto programmato, di massa, entro i cui solchi, statualmente determinati, si dirottavano i flussi di migliaia di persone. Alcuni studiosi parlano addirittura di “deportazione” economica. Per molte persone, allora, lavorare voleva dire emigrare. Ma questo binomio, tutt’altro che incidentale, non era stato scritto nella Carta costituzionale. Così accadde che partigiani scesi dalle montagne, prigionieri rientrati dal campi di prigionia dell’Europa centrale, soldati finalmente smobilitati, dopo aver combattuto sui vari fronti dell’Europa in fiamme e aver partecipato ad infauste campagne combattentistiche, improvvisamente si riscoprono di dovere combattere altre difficili battaglie, quelle per il lavoro, molte delle quali sostenute sul suolo straniero di Francia, Svizzera, Belgio, Germania,… Sì, proprio così, anche in Germania, terra di “crucchi”, lo stesso Paese che, sino a pochi lustri addietro, aveva trascinato non solo l’Italia, ma tutto il Vecchio Continente, in un’avventura bellicistica drammatica e senza precedenti. Nuovi scenari difficili da accettare, che parevano pregiudicare seriamente le conquiste ottenute durante la lotta di Liberazione nazionale. Quante vicende personali potremmo qui richiamare, per ricostruire, nel concreto, il clima di quegli anni, nell’immediato secondo dopoguerra!… Di persone in cerca di lavoro, disposte a peregrinare per terre lontane, perché il lavoro valeva il sacrificio dell’emigrazione.

Muratori valdimagnini in Svizzera nell’immediato secondo dopoguerra.
La vicenda di Franco Cassotti, un onesto partigiano
Ci limitiamo, in questo post, a seguire l’esperienza di vita dell’amico Franco Cassotti, deceduto ormai da diversi anni, già citato nella precedente riflessione sul 25 Aprile, limitatamente alla sua attività di partigiano nella provincia di Acqui. Nel 2004 ha accettato di consegnarmi la sua preziosa testimonianza, che in parte è stata pubblicata nel volume “Combattenti e reduci” del Centro Studi Valle Imagna. Basti dire che lo ricordo come una brava e onesta persona. È già molto, al giorno d’oggi. Nei mesi successivi alla Liberazione, le cose pian piano cambiarono e quasi tutti i partigiani fecero gradualmente ritorno a casa. Passato il momento, anche euforico, del 25 Aprile, quando i Partigiani e gli Americani erano osannati quali liberatori dell’Italia, le cose sono ritornate come prima. Bisognava innanzitutto deporre le armi. “Tutti noi partigiani abbiamo consegnato le armi, perché non eravamo delinquenti, soprattutto avevamo voglia di vivere in normalità e di tornare a casa. Nella mia formazione nessun comandante ha incitato a combattere ancora, magari per la conquista del potere”. Franco avrebbe voluto continuare a prestare servizio nella polizia partigiana, dove era rimasto più di un anno dopo la Liberazione, ma venne subito ammonito dal papà: – Endó ölet ‘ndà ‘ndóe? A fà ü mistìr de pelandrù? Cóse n’fét, té, de ü mistìr de pelandrù! Endèm ensèma mé, che e m’và en Svìssera!… – gli aveva ordinato, senza riserve. Fare il poliziotto non era un lavoro: per il papà, lavorare significava fare bel altro, con fatica, sudore e sacrificio. Egli si trovava in Svizzera già da un anno e in poco tempo è riuscito ad ottenere un contratto di lavoro anche per suo figlio. Nel dicembre 1946 Franco si è smobilitato dalla polizia partigiana e il mese di marzo 1947 l’à fàcc sö la alìs ed è partito per la Svizzera assieme con il papà, a La Chaux Fonds, a fare il muratore, dove è rimasto cinque anni. Aveva consegnato il suo parabèl, ma non alcune bombe a mano, che fece esplodere qualche anno dopo in un prato, per fàga fèsta a la Madóna de la Cornabüsa!

La sistemazione degli emigranti negli alloggi per i lavoratori.
La visita di Briga
Di quel primo viaggio in Svizzera, Franco ricorda in particolare la visita di Briga. “Era un treno carico di emigranti. Tutti uomini. Prima di arrivare in quella cittadina di frontiera, i gendarmi ci hanno ritirato i passaporti. Giunti a Briga siamo dovuti scendere tutti dal treno, con le valigie al seguito: – Scendere, scendere! Italiani, scendere!… – urlavano quei gendarmi, in lingua tedesca, dal modo di fare arrogante simile ai Tedeschi e ai Fascisti che avevamo combattuto sino al giorno prima!… Ma dove sono capitato? Dove sono i miei amici partigiani? Dove è il mio parabèl?… Ma non era ancora finita. Scesi dal treno, ci hanno fatto deporre, distese sul marciapiede, le nostre valigie èrte, töte ‘nfelàde dó. Intanto noi siamo stati convogliati dentro un capannone, lì appresso, dove ci hanno obbligati a spogliarci completamente nudi. Dopo la doccia collettiva in un grande stanzone, hanno proceduto alla visita medica. Ci facevano aprire bene la bocca, per vedere se avevamo tutti i denti, poi i me palpàa i testìcoi, i me schessàa ‘mpó de ché, ‘mpó de là, pò i me ardàa i öcc. Poi ci hanno fatti entrare in un’altra stanza, sempre nudi, in fila indiana, ü cül cùntra l’ótro: c’era una persona, con in mano una di quelle pompette, che si usano per mettere il verde rame sull’uva, che e l’me fletàa töcc. I me desenfetàa! Terminata anche la fase della disinfezione, cioè dopo circa due orette, ci facevano ritornare nella prima stanzona, dove ciascuno di noi doveva rovistare nel mucchio dei vestiti per cercare i propri indumenti, anch’essi nel frattempo “flittati” e disinfettati. Usciti da quel locale, sul marciapiede davanti alla ferrovia c’erano tutte le nostre valigie batìde per aria e pure flittate! Non ci era rimasto altro da fare che rimettere in ordine la nostra roba, rifacendo dunque la valigia e ritornando infine sul treno, non più quello italiano, ma quello svizzero. La visita di Briga è stata una cosa molto umiliante. Fresco ancora della mia precedente esperienza di partigiano, quindi di combattente, non è stato facile accettare questa situazione. Non solo mancavano di riguardi nei nostri confronti, ma facevano anche gli sbruffoni, quando ad esempio dicevano: “I è mia ‘gnìcc sà, ché, i Todèsch, perchè nótre mo i tredàa sö!”. Io tacevo, ma mi veniva di dire loro: “Se i ve reàa ché, i ve tredàa sö! En vintequatro ure i ve maiàa ìv!”.

Gruppo di muratori sul cantiere.
Un fornello per venti persone
Briga era solo l’inizio, una sorta di anticamera per una nuova non facile avventura, anche questa volta in terra straniera, dove Franco ha conosciuto ben presto quanto fosse “amaro” il pane sudato in quelle condizioni. “Nel 1947 ho lavorato a La Chaux de Fonds da aprile sino a fine novembre in un cantiere edile. L’impresario, Hans Bieri, ci aveva assegnato una stanzetta, dove mi ero sistemato assieme al papà e ad altri quattro muratori, uno di Sant’Omobono e tre di Gerosa. La nostra stanza era arredata da tre semplici cuccette, con due coperte e un lenzuolo, che non abbiamo cambiato una volta durante tutto l’anno! Per l’utilizzo dell’alloggio, pagavamo ciascuno un franco al giorno: era una casa vecchia, di tre piani, abitata tutta da muratori italiani. Sapete quale era la prima cosa che abbiamo fatto, appena arrivati là? Siamo andati a prendere due assi e qualche chiodo, per realizzare una mensola sopra il letto, dove riporre la nostra valigia, perché in quella stanza non c’era nemmeno un armadio. Poi, in un’altra stanza di uso comune, c’era un solo fornello per il gas, che doveva servire per venti persone, quindi era raramente disponibile e, di conseguenza, solitamente me mangiàa a söcc. A mezzogiorno stavamo in baracca, seduti sul cemento. La salute fortunatamente non mancava. Nonostante il papà non fosse più tanto giovane, non ha mai avuto alcun disturbo fisico. Mai che avesse perso una giornata di lavoro per mal di testa, influenza o altri malanni! Aveva superato i cinquant’anni di età e, nel triennio che ho trascorso con lui, non l’ho mai visto fermarsi neanche mezza giornata”.

Gruppo di muratori bergamaschi sul cantiere di Santa Margherita (San Gallo). Primi anni Sessanta
Il sabato si lavorava fino a mezzogiorno
L’emigrazione era allora ancora stagionale e il lavoro costituiva un valore assoluto. L’obiettivo, al primo posto per migliaia di connazionali, consisteva nel risparmiare il più possibile per incrementare il gruzzolo di denaro da portare a casa a fine stagione, dimostrando così che il loro sforzo non era stato invano… “Il sabato si lavorava fino a mezzogiorno. Il pomeriggio bisognava lavare gli indumenti, andare a fare la spesa e, poi, se rimaneva un po’ di tempo, facevo pure una passeggiata sulla Grande Rue. Ero giovane e mi piaceva ballare: avevo imparato in Piemonte a fare i primi saltelli. Nel Quarantasette, il sabato sera andavo solitamente a ballare, assieme ad alcuni amici di Brembilla: nella prima parte della serata e fino a mezzanotte andavamo dalla Gina, un locale vicino alla stazione, mentre dopo, dalla mezzanotte alle tre del mattino, ci spostavamo alla Casa del Popolo. E m’gh’ìa ‘ntùren e nòste morosète, che le me steràa ‘mpó i bràghe e le me laàa fò la camìsa. Lungo la Grande Rue, sotto quelle piante, diversi connazionali anziani si ritrovavano di frequente a conversare, seduti su quelle panchine. Quando ci vedevano passeggiare in compagnia di alcune ragazze, dicevano tra loro:
– I ne porterà a cà tanci, chi egliò, st’envèren!…
Una volta, uno di loro mi aveva detto:
– Ah, ti sì amò ché! Te n’porteré a cà tanci st’envèren!…
Mi ero proprio seccato e gli avevo risposto per le rime:
– E l’sìf cosè che fó, mé, quande che ó a cà? Tègne a mà söl viàss!…
Per quelle persone, il risparmio era tutto, uno stile di vita”.

Emigrazione di minatori italiani in Belgio nell’immediato secondo dopoguerra.
Non posso ballare con un italiano
L’emigrazione italiana in Svizzera è stata per molti anni una presenza silenziosa, preoccupata di mantenere il posto di lavoro, lontana da ogni tipo di rivendicazione sociale, non indirizzata a sostenere alcun processo di integrazione, soprattutto alla luce dei diversi comportamenti riluttanti degli Svizzeri nei loro confronti.
“In quel periodo a La Chaux de Fonds gli Italiani non erano benvisti. Semplicemente venivano tollerati. Vi racconto questo fatto. Avevo invitato una signorina svizzera a ballare, la quale per due volte ha accettato, ma al terzo invito mi ha risposto:- No, non posso più ballare con un italiano!…
Era stata probabilmente richiamata dai suoi genitori. Io, tra l’altro, ero tra gli italiani che si vestivano bene e non si comportavano male. Sapendo di trovarmi in casa d’altri, non andavo mai in giro sporco o ùcc: ho sempre cercato di stare attento, presentandomi con educazione e ben ordinato. Anche quando capitava di entrare nei caffè e ci si trovava seduti accanto agli Svizzeri, alcuni di essi arrivavano al punto di girarsi, voltandoci la schiena, e dicendo a mezza voce:
– Sales macarunì!…
In quelle circostanze non c’era niente da fare, quindi bisognava sopportare in silenzio, perché altrimenti essi avrebbero chiamato la polizia, con il rischio per noi dell’espulsione. Altri svizzeri, invece, finivano di bere quello che avevano sul tavolo e prima possibile si alzavano, quindi andavano a sedersi da un’altra parte”.

Emigrazione di minatori italiani in Belgio nell’immediato secondo dopoguerra.
Lo sapevano bene quei combattenti
Franco, e come lui tanti altri valligiani, lavoratori ed emigranti, hanno compreso presto, a loro spese, che la vita è un continuo susseguirsi di vicende alterne, da gestire in modo prudente e mai da sottovalutare. La loro generazione ha saputo ricostruire l’Italia, riscattandone le sorti, utilizzando lo strumento che è sempre stato più congegnale al nostro popolo: il lavoro. Con tanti sacrifici. Perché la libertà senza il lavoro è una conquista troppo fragile e può venir meno da un momento all’altro: lo sapevano bene quei combattenti!..