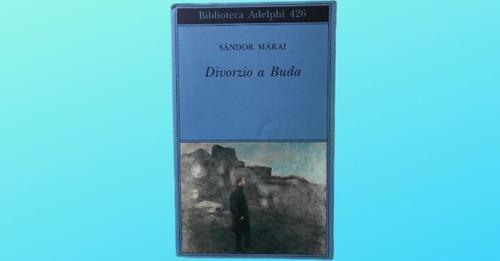L’economia della montagna è tuttora spesso percepita come un sistema di relazioni e produzioni connesse per lo più all’allevamento zootecnico e alla trasformazione del latte in caseus. E ciò, almeno in parte, è vero, ma non possiamo dimenticare molte altre attività rilevanti per il sostentamento del gruppo familiare, sia sotto il profilo alimentare, che per quanto concerne l’introito di qualche pur modesta somma di denaro… sempre utilissimo e persino provvidenziale. La tenuta e la gestione del pollaio è una di queste diverse componenti, poco considerata, ma determinante. Ogni casa la gh’ìa ol sò polèr col serài, costituiti il primo da ü stalì, dentro il quale la notte trovavano riparo le galline, mentre il secondo da un modesto spazio esterno recintato, all’interno del quale il pollame razzolava all’aria aperta e veniva alimentato, en dol sò àlbe, col pastaròt, composto da una miscela variabile a base di granoturco, crusca, avanzi della cucina domestica, con l’aggiunta di radicchio, cicoria, ortiche o altre erbe tagliuzzate, ottenute dalla pulizia degli spazi circostanti alla casa. Perché l’öf e l’vì dal bèch.

In talune circostanze ol serài poteva anche essere coperto con pèrteghe e bròche. I due ambienti sono sempre collegati e, nella parte bassa della porta lignea dello stalì, öna bösaröla consente alle galline di andare e venire dal polèr anche durante il giorno, perché all’interno trova spazio la casèta di öv, che può essere collocata anche in una nécia dol mür, resa accogliente da un semplice giaciglio di paglia. Durante il giorno, qualcuno della famiglia – un compito molte volte assegnato a bambini e ragazzi – doveva tenere d’occhio il pollaio, soprattutto quando le galline venivano liberate per razzolare liberamente nel prato circostante (non certo prima della fienagione), beccando lombrichi e altri animaletti che vivono a contatto con la terra, oppure sull’èra della corte domestica, dove i pigolii dei pulcini al seguito della chioccia, il canto del gallo, il chiocciare continuo delle galline ruspanti costituivano un sorta di colonna sonora del contesto rurale familiare. Ol tata le voleva però lontane dalla stalla, perché le ga sgargiàa entùren ol rüt e le ga desfàa dó la mìda de la méssa. Un paesaggio sonoro e visivo assai particolare, dove tutto pareva così spontaneo e naturale. Sull’imbrunire, poi, utilizzando anche gli ultimi sprazzi di luce, prima di concludere le attività della giornata e de stangà fò ol purtù de la cà, la regiùra ordinava a una ragazza de ‘ndà a serà sö i galìne, che venivano fatte entrare nel polèr, per poi chiudere la bösaröla durante la notte, allontanando così il pericolo di un eventuale attacco di volpi e faine. All’interno del polèr, dò o trè pèrteghe sospese tra una parete e l’altra e fissate al muro consentono alle galline de ‘ndà a lòs, ossia di appollaiarsi per la notte. L’espressione endà a lòs, infatti, significa andare a dormire.

La tenuta del pollaio non era finalizzata solamente alla produzione in proprio di uova e carni di qualità da consumare in famiglia, bensì orientata anche alla vendita; la sua composizione un tempo era limitata a pochi bipedi: cinque o sei galline ovaiole, due o tre polli e il gallo. Non tutti i pollai potevano vantare di avere anche uno o due pulì, che venivano uccisi e cucinati per le grandi occasioni, onorando così le feste principali della famiglia. Gli alimenti di origine animale della famiglia contadina di queste parti sono presto detti: la mucca con d’ü mansolèt e la pìgora nella stalla, le galline en dol polèr. Non c’erano altri animali, fatta eccezione per qualche coniglio. Su questa base alimentare gli abitanti della montagna ià sémpre mangiàt. Magari ci si accontentava di un piatto di minestra di riso o di latte la sera, di pult la mattina, prima di andare a scuola, o a pascolare le mucche, oppure a lavorare nel bosco. Nei momenti migliori c’erano le castagne e, l’inverno, il maiale. E s’mangiàa chèl che s’gh’ìa. A mesdé ‘mpó de polénta, ü öv, ü ciarighì o póch d’ótro. Quande a Nedàl la regiùra la fàa bói ü polastrèl, l’ìa fèsta granda. Di fronte a contingenze particolari, in diverse famiglie le uova non si mangiavano, ma si vendevano, per ciapà dò palanche, e la carne compariva sulla tavola solo a Natale e a Pasqua. A mezzogiorno, a la malparàda, e s’mangiàa polénta e ciarighì, con ciàra e burlìna còcie ensèma, oppure una semplice frittura di làrd pestàt, nel cui tegamino si intingevano pezzetti di polenta e… come erano gustosi!… In realtà, ancora oggi, ü ciarighì o öna fretàda sono un piatto nutriente subito pronto, a qualsiasi ora, ma anche ü öv còcc consàt dó con l’ensalàda – capelìne o secòrgne – la primaìra, oppure ü öv scoldàt da bìv dó. Ai segadùr, fò en dol pràt, en tép dol fé, già provati dalla fatica, a metà mattina si portava en dol tulì öna bèla rösömàda, che li avrebbe almeno in parte ritemprati, assimilando così le ulteriori energie necessarie per portare a compimento il grave lavoro.

Patrizio Mazzoleni di Saiàcom mi raccontava che le figlie di suo zio le ‘ndàa dó en dol serài a tastà i galìne, per riferire poi alla nonna: “Ià facc dis öv, quande che le gh’ìa da fàn dùdes!…”. Sua mamma, infatti, ogni tanto sottraeva di nascosto un uovo o due dal serài, per pagare una medicina, oppure per acquistare un etto di zucchero, quale ricostituente per i figli più piccoli e delicati. L’anziana madòna della famiglia, invece, voleva conoscere e amministrare personalmente il quantitativo esatto di uova prodotto nel suo polèr e le spuse de la cà dovevano rivolgersi direttamente a lei per qualsiasi richiesta o necessità. Nelle contrade dell’Alta Valle Imagna, ma non solo, passavano, casa per casa, con regolarità, ol loaröl o la loaröla a raccogliere le uova nelle varie famiglie. A San Simù, sino a tutti gli anni Sessanta, gh’ìa ol Ragiùna, che l’vàa a sercà sö i öv col so dèrel sö i spale: ritirava dondéne de öv, il cui prezzo era da contrattare e scambiare con i suoi articoli per la casa: con tate dondéne de öv te tülìet taci méter de stòfa, per fà dét öna o dò bràghe. Prima ancora, da Föppia e Alsèca, da San Simù e Locadèl, da Röda e Brömà, diverse loaröle, col derelì sö i spale, oppure col caagnöl en de mà, svalicavano fò en Seràda, oltre il Pertüs e la Passàda, per recarsi nel lecchese a vendere la preziosa merce, dove le ciapà ergót de piö. Il lunedì di Pasquetta, invece, in valle si potevano sacrificare alcune uova sode perché i giovanotti potessero gareggiare sui prati di San Piro, facendole rotolare lontano, senza romperle. Oppure, per le grandi occasioni, le uova erano materia prima per fare lo zabaglione con il marsala, una leccornia senza tempo…
 Se, un tempo, dalla vendita delle poche dondéne de öv, come anche de ü galèt o de öna galìna dol serài, amministrata dalla regiùra o da altre donne della casa, si riusciva a far fronte ad alcune necessità domestiche spicciole, al giorno d’oggi dall’allevamento delle galline ovaiole anche in montagna possono svilupparsi nuove forme di economia rurale, come quella messa in atto fò ‘n Val Piàzza, nel villaggio di San Simù, da Dario, loaröl dei tempi moderni, che con le sue duecentocinquanta galline libere e ruspanti produce e vende oltre cinquemila uova biologiche al mese.
Se, un tempo, dalla vendita delle poche dondéne de öv, come anche de ü galèt o de öna galìna dol serài, amministrata dalla regiùra o da altre donne della casa, si riusciva a far fronte ad alcune necessità domestiche spicciole, al giorno d’oggi dall’allevamento delle galline ovaiole anche in montagna possono svilupparsi nuove forme di economia rurale, come quella messa in atto fò ‘n Val Piàzza, nel villaggio di San Simù, da Dario, loaröl dei tempi moderni, che con le sue duecentocinquanta galline libere e ruspanti produce e vende oltre cinquemila uova biologiche al mese.
Contributo di Antonio Carminati, Direttore del Centro Studi Valle Imagna